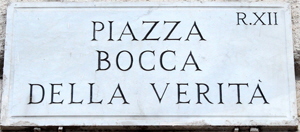|
STRADE DELLA ROMA PAPALE |
|
Piazza (ex Via) Bocca della Verità (R. XII – Ripa) (vi convergono: via del Velabro, via di San Giovanni Decollato, via Luigi Petroselli, via di Santa Maria in Cosmedin, via della Greca, via dei Cerchi) Ha avuto il nome da quel mascherone , antico tombino di fogna romana, che era addossato al muro esterno di S. Maria in Cosmedin, e che dal 1632 fu trasportato nel portico della basilica. Si vuole che fosse l’imboccatura di una fogna, non stradale, del Tempio d’Ercole Vincitore, anche per i “vari simboli di ex voto scolpiti o in cavo o in rilievo attorno alla faccia principale”. Alla Bocca l’attributo Verità venne da una leggenda medioevale, che partendo dal concetto che il poeta Virgilio fosse un mago ed un maliardo, diceva come questi avesse fatturato il mascherone in modo che chi, ponendo la sua mano nella bocca che forava il tombino, pronunziasse un giuramento falso, ne avrebbe avuta stroncata la mano. Anzi, per precisione, tale trappola era stata escogitata da Virgilio per le donne infedeli, ed infatti uno scritto del sec. XIV era intestato “Di una effige in Roma che strappava coi denti, le dita alle donne adultere”. La sua sede fu, come spesso avvenne per le diaconie[2], stabilita in edifici pubblici dell´età romana. Così Santa Maria in Cosmedin è penetrata in parte nella cella del tempio di Cerere[3] e con l’abside e l’altare della chiesa in parte della "statio annone". I 2 templi scoperti al Santo Omobono (vico Iugarius), di antichissima fondazione e di fattura gemella, se il Foro Boario si estendeva fino al "vicus Iugarius", sarebbero quelli della Mater Matuta e della Fortuna, la cui sorte è stata sempre legata, quasi a farne un santuario solo. Infatti ambedue vengono attribuiti a Servio Tullio (578-534 a.C.) che alla dea Fortuna attribuì il merito di essere, da schiavo, diventato re. La dea Matuta era venerata particolarmente dalle donne, che nelle feste dette "Matralia" che si celebravano l'11 giugno durante le "Vestalia" per l'annuale della dedicazione del suo tempio, portavano in braccio i nipoti in luogo dei figli, perché Leucotea (identificazione della dea Matuta), aveva allevato Dionisio, figlio di sua sorella Semele. L’offerta era una rustica focaccia. Altro rito era condurre una serva nel tempio (al foro boario), percuoterla e cacciarla fuori. Ma se il Foro Boario non aveva la suddetta estensione, i templi sarebbero i due superstiti in piazza Bocca della Verità: quello rotondo, che fu trasformato nella chiesa di Santo Stefano delle Carrozze e l'altro rettangolare in quella di Santa Maria Egiziaca. In questo tempio Tiberio Sempronio Gracco avrebbe posto questa epigrafe: “Tib. Semproni Gracchi consulis imperio auspicioque legio exercitusque populi Romani Sardiniam subegit. in ea provincia hostium caesa, aut capta supra octoginta milia. republica felicissime gesta atque liberatis Vectigalibus restitutis, exercitum salvum atque incolumem plenissimum praeda domum reportavit; iterum triumphans in urbem Romam redit. cuius rei ergo hanc tabulam donum Iovi dedit”. Il tempio della Fortuna al Tempio del Forum Boario, ch’è da alcuni attribuito alla "Fortuna virile" e secondo altri a “Giove ed al Sole"[4], per una lapide che si dice rinnovata dal cardinale Giulio Santorio, sembra invece agli archeologi moderni debba identificarsi con quello di "Portunus" o "Portumnus". Così per la dedicazione alla "Fortuna virile"; dice Giuseppe Lugli che un tempio a questa dea è ricordato da Plutarco (50-120), e dai Fasti Prenestini[5] al primo di aprile e attribuito a Servio Tullio (578-534 a.C.). È dubbio però se si tratti di un tempio indipendente, o non piuttosto di uno di quelli già noti; infatti il nome non è che una cattiva interpretazione fatta dagli stessi antichi di "Sors" o "Fors Fortuna" che vuol dire la stessa cosa, e non ha nulla a che vedere con forte e virile. L'archeologo Lugli dunque crede fermamente, e con lui altri, che il tempio della Fortuna sia uno dei due che sono stati recentemente ritrovati a Sant’Omobono, mentre l'altro l’identificherebbe con quello della dea Matuta. Invece che alla "Fortuna”, il tempio rettangolare, lo dice dedicato a "Portunnus", divinità protettrice del porto Tiberino, introdotta in Roma dopo la conquista di Ostia[6] (358 a.C.) e dopo la formazione di una flotta commerciale romana, che faceva scalo al porto civile. Il 17 di agosto vi si celebravano in suo onore le "Portumnalia" intitolate a questo "Deus portuum portarumque praeses" e come dice Festus (II sec. d.C.) "Portum frequenter maiores pro domo posuerunt". Sotto Giovanni VIII (872-882), romano, che fu il primo ad assumere il titolo di Papa[8], dal secundicerius Stefano, fu dedicato il Tempio a Maria Vergine e secondo un censuale vaticano del 1403 e nel catalogo del Camerario (Cencio Savelli, XI-XIII sec.) è chiamata "Santa Maria Secundiceri". Aveva questo attributo perché vicino ad essa era una delle residenze del "Secundicerius" che era il secondo dei sette personaggi della corte papale del secolo VIII[9]. Pasquale II (1099-118) per sfuggire al gioco delle fazioni ed ai seguaci dell'antipapa Bordino, si ritirò nelle vicinanze di questa Chiesa, i cui dintorni erano validamente difesi dai serragli e dai fortilizi turriti di Stefano Normanno, di suo fratello Pandolfo, di Pietro Latro, dei Corsi. Pio V (1566-72) la concedette nel 1571 "alla nazione armena", che aveva dovuto abbandonare l'altra concessale da Pio IV (1559-65) a ponte quattrocapi, perché demolita per l'ingrandimento del ghetto[10]. Al possesso degli Armeni, la chiesa di Santa Maria Secundicerii fu dedicata a Santa Maria Egiziaca ed, in un locale annesso, funzionò uno spedale per i pellegrini armeni che venivano a visitare Roma. Fu restaurato insieme alla chiesa da Clemente XI (1700-21) e a destra, uscendo, vi fu poi messo il modello della cappella del Santo Sepolcro di Gerusalemme, che il giovedì santo richiamava un'infinità di persone per la visita di rito. Nel 1930, abbattuto l'annesso edificio, sul fianco orientale del tempio, apparvero le tracce di alcune taberne, consistenti nei resti di pareti tufacee, che si avvicinavano al piccolo edificio, circondato da un pavimento lastricato. Altro dubbio che sorge, è quello se "Fortuna in Forum Boario”, sia la stessa cosa della "Fortuna Seiani". Infatti è risaputo che fino al tempo di Plinio (23-79), nell'interno del tempio si custodiva un simulacro antichissimo della dea, in legno dorato[12], che era sopravvissuto all'incendio gallico del 390 a.C. ed a un altro nel 213 (dopo Canne (216)). Ci dice Plinio che alla morte di Seiano, ucciso da Tiberio nel 31 d.C., bruciarono le due toghe della statua, ma non da notizia né della statua, né del tempio, quindi ci resta ignoto e la fine del simulacro e se questo fosse lo stesso che era adorato nel foro Boario. Il Tempio di Matuta al Forum Boario è vittima, ancora una volta di una dubbia interpretazione sulla divinità titolare del tempio: "Questo elegantissimo tempio romano, detto volgarmente di Vesta, è costruito in marmo lunense, ed è circondato da 20 colonne scanalate dello stesso marmo, d'ordine corinzio[14]. Può ritenersi opera d'artefice greco, ma s’ignora a quale divinità fosse consacrato; il nome Volgare di Vesta è fondato solamente sulla sua forma circolare, perché il tempio di Vesta sorgeva nel Foro Romano, ove se ne veggono di avanzi. Alcuni opinano fosse l’ "aedes rotunda Herculis” ricordata da Tito Livio, ma più probabile ed accreditata è l'opinione che debba riconoscervisi il tempio di Cibele". “Nel XII secolo dai Savelli, che avevano poco lontano, sull’Aventino[15], il loro castello[16], fu trasformato in chiesa e dedicato a Santo Stefano. Si chiamò prima delle Carrozze, dalla vicina omonima strada che in linea retta conduceva dietro Santa Galla, ed è chiamata dall'anonimo di Torino (XIV sec.) e da Cencio Camerario (XII-XIII sec.), Santo Stefano Rotondo che distinguono quello del Macellum Magnum coll'appellativo di “Santo Stefano in Coelio monte". (Armellini). Cambiò il titolo in quello di “Santa Maria del Sole" quando, secondo il Bruzio (XVII sec.), "l'anno 1560, in quelle adiacenze viveva donna Giromina Latini, vecchia di 115 anni che a Dio aveva la sua verginità dedicata[17]. Il fratello di lei, passando sul Tevere vide galleggiare un'immagine della vergine dipinta in papiro e la prese e la dette alla sorella che fra le gemme del suo scrigno la chiuse. Dopo alcuni giorni, nell'entrare in camera, vide l'immagine risplendente come il sole e così cinta di raggi”. Tutta Roma corse alla fama del prodigio, e dal miracolo fu detta Vergine del Sole, cambiandosi in edicola l'atrio di quella casa. Poi l’arciconfraternita della Santa Croce presso S. Marcello trasferì nel suo nuovo oratorio quell'immagine incidendone in marmo la seguente memoria: “I.O.M. Hieronymae De Latinis E Nobili Prospaia Matronae Quae Pudicitia Caritate Et Castitate Omnes Sui Temporis Excelluit Huius Oratorii Excitatrici Quae Cum Ad Centum Quindecim Suae Aetatis Annum Virgo Permansisset[18] Haud Immatura Morte Functa Est Pia Societas Crucifixi". Nel lato posteriore del tempio rotondo (detto tempio di Vesta), sulla parete marmorea, liberata adesso dall'intonaco, compare un calice sormontato dalla croce ed un vaso da bere, ambedue dell'antica forma del calix e del poculum dei Romani. Il tutto graffito e con aggiunti certi circoli che significano dei pani, lavoro di un ignoto cristiano del VI secolo all'incirca che volle imprimere su quelle mura pagane un certo carattere religioso[20]. Come pure nel portico, sulla parete esteriore di marmo della cella sono praticate rozze irregolari strisce e incavature per tutta l’altezza della medesima. Esse vennero fatte nel Medio Evo allo scopo di tener saldo uno strato di calce, sul quale si doveva dipingere, quando il tempio era diventato la chiesa di Santo Stefano.
[1] ) Cave mulierem in omni casu. [2] ) Diaconia e titoli - L'istituzione dei diaconi della Chiesa romana, è attribuita al Papa Fabriano (236-50), ma deve essere più antica, forse risale ai tempi apostolici, in analogia ai sette diaconi della chiesa di Gerusalemme. Sette furono in origine i diaconi romani preposti ciascuno ad una delle sette regioni ecclesiastiche in cui fu divisa Roma. Queste diaconie, a giurisdizione territoriale, corrisposero ad una necessità della vita dei cristiani, nei primi secoli dell'impero. [3] Un tempio a Libero, Proserpina e Cerere era presso S. Maria in Cosmedin, ex voto del Dittatore Postumio nella guerra contro i Latini (225). Il tempio insieme con Cerere e Libera segna la prima introduzione del frumento già coltivato ed in uso nelle terre conquistate, ma ignoto ai Romani (Plinio XVIII-II) nei primi 3 secoli, durante i quali la sola grascia (cereale) da essi usata fu il farro. Decorato da Gorgasos e Damophilos, il tempio accoglieva in parità plebei e patrizi. Dal 449 a.C. fino all’impero vi risiedettero i tribuni edili e della plebe e nei sotterranei custodiva il denaro delle ammende. Culto di sacerdotesse campane. Vi si celebravano i “Ludi Cereales” in aprile ed in agosto il “sacrum anniversarium Cereris” con feste che duravano 9 giorni, nei quali le donne , che più non avevano rapporti con uomini vestivano di bianco, emblema di purezza. [4] ) Altro presso il Circo Massimo. In occasione della scoperta di una pretesa congiura contro Nerone, dice Tacito nel XV libro-74: "Furono allora decretate offerte votive e grazie agli dei, un particolare onore fu tributato al Sole, il cui antico tempio sta appresso il circo...". Altro tempio del Sole, secondo il Fauno (XVI sec.) esisteva alla Trinità dei Monti. [5] ) Rinvenuti dal 1577 in poi in varie riprese. Trattano di alcuni giorni solamente fra gli anni 3 e 10 d.C.; furono compilati ed annotati dal grammatico M. Verrio Flacco, maestro dei nipoti di Augusto. [6] ) A Porto aveva un altro tempio che viene identificato con quell'edificio rotondo a sinistra della via presso l'ingresso della tenuta Torlonia. Anzio ebbe un tempio dedicato alla "Fortuna equestre" cui, sotto Tiberio fu portato il dono votato dai cavalieri romani per la salute di Giulia Augusta. [7] ) A fianco della Riva del Tevere si trovava un bacino di carenaggio per bastimenti di guerra detto, nella "Forma Urbis", "Navalis inferius”: esso era situato quasi di fronte all'Isola Tiberina, un po' a valle del ponte Sublicio che sbarrava la via alla navigazione di sud-est. In quest'arsenale furono trasferite, nel 338, le navi tolte agli Anziati; di là partì, nel 394, la "navis longa" con l'anatema per l’Apollo Pitio; nel 57, Catone vi sbarcò il tesoro del re Tolomeo e nel 291 vi fu ancorata la nave (Lugeo) che trasportava il serpente sacro di Esculapio. Più a sud dei “navalia inferiora" v’era lo scalo dell' “Emporio”. I “Navalia superiora" capaci di lunghe navi e fornite di bacino, che accolsero le navi regie tolte ai Macedoni, stavano di fronte ai "prata Quinctia", fu là che gli ambasciatori del senato invitarono Cincinnato ad assumere la dittatura. (Livio, III, 26) [8] ) Giovanni VIII (872-882) - Di questo Papa, che pur combattendo valorosamente, vinse i saraceni nella battaglia navale di Porto, seppure in seguito venne con essi a patti obbligandosi di pagare un tributo annuo e che edificò Giovannipoli, è detto per ischerno "Giovanna la Papessa". [9] ) Essi erano precisamente: Il “Primicerius, il "Secondicerius” dei notari, “l’Arcarius”, il “Sacellarius”, il “Protoscrinarius”; il “Primus defensor”, e il “Nomenclator”. [10] ) La chiesetta, che era rimasta compresa nel serraglio degli ebrei è perciò dissacrata ed abbattuta, era detta S. Lorenzo dei Cavallucci o de Gabellutis e sembra abbia anche portato l'attributo "de mundezariis” o "de mundezarie" o "de’ Cavallini", "de Caballis", "Petri Leonis" e “de fulmine". [11] ) In Roma antica: pozzo cilindrico scavato nei pressi dei templi, destinato a deposito di oggetti votivi per sottrarli a furti e profanazioni. [12] ) "Fortuna aurea" era quella collocata nella camera da letto degli imperatori [13] ) Dette una toga “pretexta" e l'altra "ondulata". [14] ) Una colonna mancante si crede debba essere quella innalzata nel Foro Romano all'imperatore Foca (602-610). [15] ) V'erano sull’Aventino due località dette: "Laureta maior” e “Laureta minor”. [16] ) Vedi ”Via di San Saba” (Ripa-Aventino-San Saba). [19] ) Marco Fulvio Camillo: "...ludos magnos ex senatus consulto vovit captis se facturum aedemque Matutae Matris refectam dedicaturum, iam ante ab rege Ser. Tullio dedicatam”. E infatti, alla caduta Veio: "Tum Iunoni reginae templum in Aventino locavit, dedicavitque Matutae Matris”. (Livio, V, 19 e 23). [20] Così nell'atrio della basilica di San Clemente dove, sopra la prima colonna destra, è graffita la croce monogrammatica come pure nel vestibolo di S. Pietro, l'ultima delle colonne anteriori a destra, presenta il monogramma circondato da Alfa e Omega. |
|
|